 Fa notizia in questi giorni una sentenza della Corte di Strasburgo, emessa a seguito di un ricorso di una coppia italiana che voleva dare ai figli il cognome della madre (vietato in Italia) che riconosce la discriminazione tra coniugi, laddove non sia ammessa la possibilità di attribuire il solo cognome materno ai figli. Stabilisce, infatti, la Corte:
Fa notizia in questi giorni una sentenza della Corte di Strasburgo, emessa a seguito di un ricorso di una coppia italiana che voleva dare ai figli il cognome della madre (vietato in Italia) che riconosce la discriminazione tra coniugi, laddove non sia ammessa la possibilità di attribuire il solo cognome materno ai figli. Stabilisce, infatti, la Corte:
…se la regola che stabilisce che ai figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della convenzione europea dei diritti umani, l’inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell’iscrizione all’anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne.
E’ una buona sentenza che ha un forte valore simbolico e anche un potenziale di rinnovamento del pensiero e della cultura di grandi dimensioni.
Per capire come mai la decisione della Corte abbia un valore così grande, occorre fare una breve storia della famiglia e del diritto di famiglia. Osservare il sistema di norme che regolavano la famiglia è interessante ed utilissimo perché in questo campo, più che in tutti gli altri, le scelte del legislatore sono state dettate dall’osservazione della società. L’organizzazione e la struttura della famiglia sono rimaste pressoché invariate dal medioevo fino ad anni recentissimi, con poche eccezioni, di breve durata.
Durante il XII secolo, con la riscoperta del diritto romano, grazie al giurista Irnerio, si affermò un tipo di famiglia volta a tramandare il potere di padre in figlio, sia in ambito politico, sia in ambito economico. La figura dell’uomo, del “paterfamilias” si rafforza notevolmente, sia nei rapporti patrimoniali della famiglia, sia in quelli personali. I figli, di fatto “appartenevano” al padre che aveva su di essi una potestà perpetua. Poteva castigarli e addirittura chiederne la carcerazione. Il padre aveva un controllo totale dei figli anche per quanto riguardava le loro nozze, spettando a lui dare il consenso all’unione dei figli, senza il quale, il matrimonio non poteva celebrarsi. Anzi, ai padri spettava, in sostanza, la scelta del partner che i figli e le figlie avrebbero sposato. L’uomo non aveva un potere forte solo sui figli, ma anche sulla moglie, di fatto, anch’ella una “sua proprietà”, visto che egli deteneva lo ius corrigendi sulla moglie che andava, al pari dei figli, educata e che poteva essere picchiata al fine di ridurla all’obbedienza. La figura del marito/padre era centrale anche nei rapporti patrimoniali, perché, di fatto, l’uomo era il dominus indiscusso della casa e del patrimonio famigliare.
Persino la dote (istituto giuridico di antichissima data e che è sopravvissuto attraverso i secoli, anche quando formalmente abolito), pur essendo costituita da beni appartenenti alla donna che la recava con sé al momento delle nozze, era, di fatto, amministrata dal marito. Non solo: Bonifacio VIII arrivò di fatto, attraverso un suo intervento in materia dotale (chiamato “Licet”) ad eliminare il principio dell’inalienabilità della dote, facendo in modo che in pratica, il marito non solo potesse godere e amministrare i beni della dote, ma ne fosse anche il pieno padrone e signore, lasciando la moglie estraniata persino dalla stessa dote che ella apportava al matrimonio. L’età moderna non apportò grandi mutamenti nel regime giuridico della famiglia.
Tutte le norme andavano nella direzione di salvaguardare i beni famigliari, soprattutto attraverso gli istituti della primogenitura e del fedecommesso. La primogenitura prevedeva che tutto (o quasi) il patrimonio passasse nelle mani del primo figlio maschio, alla morte del padre. Attraverso il fedecommesso, invece, si dava una destinazione predeterminata a gran parte del patrimonio che veniva esclusa dalla successione (di solito ne beneficiava il primogenito maschio).
Nemmeno il secolo dei lumi arrivò mai a sostenere la perfetta parità tra donna e uomo, benché la subordinazione femminile non fosse giustificata con una presunta inferiorità intellettuale delle donne, ma sulla base della loro debolezza fisica e biologica, dando così una spiegazione “naturale” dell’inferiorità femminile, concezione di difficile superamento persino ai nostri giorni.
Solo il vento della Rivoluzione francese portò significativi mutamenti nell’ordinamento giuridico della famiglia. I principali furono la laicizzazione del matrimonio e l’introduzione del divorzio. I figli maggiorenni non avevano più bisogno dell’autorizzazione del padre per sposarsi e tra i motivi di divorzio non compariva l’adulterio. Vennero istituiti tribunali speciali per le materie che riguardavano la famiglia (i “Tribunali di Famiglia”), la potestà sui figli era esercitata da entrambi i genitori, ai fini della successione i figli naturali erano assimilati a quelli legittimi e si ampliò anche la possibilità di adottare persino a donne e uomini single. Permase però l’amministrazione dei beni patrimoniali in capo al marito e la potestà maritale sulla donna, per la sua asserita inferiorità naturale e biologica, venne mantenuta.
E nemmeno la Rivoluzione Francese riuscì a affermare il concetto di parità tra donne e uomini, anzi. Alla fine i circoli attivi femminili vennero chiusi e Olympe de Gouges (attivissima partecipante ai moti rivoluzionari e, tra l’altro, autrice di un’audace “Dichiarazione dei diritti della donna”) venne fatta ghigliottinare da Robespierre “per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso e per essersi immischiata nelle cose della Repubblica”.
Dopo la Rivoluzione Francese, si imposero due codici: il Codice Napoleonico e l’ABGB di Francesco I d’Austria. Il primo restituì stabilità ad un tipo di famiglia di stampo fortemente patriarcale, ripristinando il principio di autorità del capo-famiglia (ancora una volta il padre, la figura maschile) che tornava ad avere voce in capitolo sul matrimoni dei figli anche dopo la loro maggiore età, poteva nuovamente richiederne la carcerazione e godere dell’usufrutto dei loro beni fino alla maggiore età. Vennero nuovamente introdotte distinzioni tra figli legittimi e figli naturali e l’adozione venne fortemente limitata. La moglie era fortemente assoggettata al marito, gli doveva obbedienza, era obbligata a seguirlo ovunque egli volesse stabilirsi e non aveva autonomia giuridica per quello che riguardava il patrimonio. Anche il divorzio venne fortemente limitato e si introdusse la differenza di valutazione tra l’adulterio commesso dalla moglie (più grave) e quello commesso dal marito (meno grave).
Meno autoritaria, invece, era la figura del marito/padre nel codice austriaco, sia nei confronti dei figli, sui quali esercitava la patria potestà ma con dei limiti, sia nei confronti della moglie che aveva autonomia giuridica sul proprio patrimonio e poteva stare in giudizio.
Ulteriori riaffermarsi della ferrea potestà maritale e della patria potestà avvennero nei Codici dell’Italia pre-unitaria, caduto l’Impero napoleonico. Nel Codice Pisanelli, il primo codice unitario, il divorzio viene cancellato, la dote che formalmente era scomparsa, ma persisteva nella prassi, torna in auge, la donna torna giuridicamente incapace per quello che riguarda gli atti concernenti il patrimonio. L’adulterio restava più grave se commesso dalla donna e persino le botte che l’uomo dava alla donna erano causa di separazione solo se continue e ripetute. La patria potestà di fatto era esercitata dal padre, anche se attribuita ad entrambi i genitori. Fu limitata l’adozione, mantenuta una netta distinzione tra figli legittimi e figli naturali, sancita una svalutazione delle attitudini pedagogiche della donna (furono istituiti i “Consigli di famiglia” che intervenivano in materia di educazione dei minorenni che restavano privi di padre), così la predominanza della figura maschile fu netta e inamovibile.
La situazione del diritto di famiglia non migliorò, per le donne e i bambini, nemmeno negli anni successivi. Il ventennio fascista celebrava la figura della donna solo come madre (curioso che la donna venisse relegata a fare la madre, quando se ne mettevano in dubbio le capacità pedagogiche e persino quelle giuridiche, togliendole la possibilità di decidere in autonomia di se stessa e dei propri figli!) e veniva esaltato il mito del macho, della virilità machista e stereotipata.
Le prime basi di una effettiva parità dei coniugi, le pose la Costituzione con gli articoli 29 e 30, ma essa divenne effettiva solo nel 1975, con la cosiddetta “riforma del diritto di famiglia” attuata con la Legge 19 maggio 1975 ed ancora attualmente in vigore. Perché ho fatto questo lungo, sebbene superficialissimo excursus nella storia del diritto di famiglia?
Ho voluto mostrare come, fino a tempi recentissimi, fosse ovvio che il cognome della famiglia, quello che veniva tramandato ai figli e che era persino aggiunto al cognome della donna, fosse quello del padre/marito. Di fatto egli era “padrone” dei propri figli e della propria moglie. Ovvio, quindi, che essi venissero “marchiati” con il cognome del loro proprietario.
Oggi donne e uomini, padri e madri, moglie e mariti, hanno pari capacità giuridica e pari diritti, uguali doveri e identica posizione all’interno della famiglia, per lo meno nelle parole della legge. Giusto, quindi, che cada anche l’ultimo retaggio culturale che vede “prevalente” il cognome del padre. Il cognome è ben più che un’inezia, una consuetudine pratica.
E’ un simbolo. Un simbolo del permanere della maggiore importanza dell’uomo (e del padre) all’interno della famiglia e della società. Ora questo simbolo è stato messo in discussione. E’ anche la caduta di una forte contraddizione che permane nella nostra società. Perché, mentre i media, la cultura dominante, le rappresentazioni femminili, l’educazione impartita a scuola mostrano come “ruolo naturale” della donna quello della madre, il cognome che i figli devono portare è quello paterno? Perché, se ci dicono che la donna è donna in quanto madre, i suoi figli non portano il suo cognome? Perché se ci insegnano che il massimo coronamento della femminilità, la piena realizzazione della donna è la maternità, i figli non portano il cognome materno? Si spinge la donna ad auto-relegarsi in casa, chiusa nel suo ruolo di madre, senza però darne riconoscimento simbolico attraverso l’attribuzione del cognome materno ai figli, svuotando simbolicamente di importanza il contributo materno, l’autonomia femminile, il ruolo delle donne nella costruzione di nuovi individui, perché i figli portano comunque il “nome di famiglia dell’uomo”.
Ho letto le parole della Corte di Strasburgo con grande stupore. E’ la prima volta che assisto in prima persona ad un intervento istituzionale in grado di cambiare la cultura, ad un intervento in materia famigliare che non recepisce l’osservazione della società, ma che la innova, la spinge al cambiamento, che le impone un’accelerazione sulla strada del cambiamento in senso paritario.
Come hanno risposto gli Italiani alle parole della corte? I primi commenti on line della “gente comune” agli articoli che riportavano la notizia, sono stati abbastanza sconfortanti. Alcuni liquidano la faccenda come poco importante (le donne e i loro diritti sono sempre meno importanti, c’è sempre qualcosa che ha più urgenza, secondo loro).
Altri inneggiano alla distruzione della famiglia, della figura paterna, con i soliti argomenti omofobi e maschilisti (in un commento che ho letto si dice che la sola funzione del padre è quella di essere un bancomat).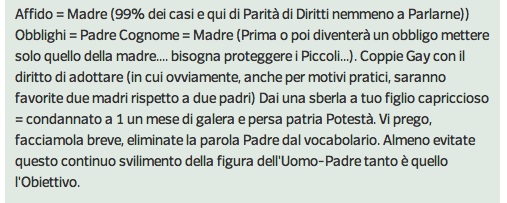
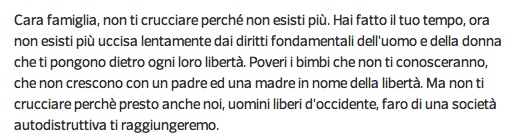

Curioso che per alcuni l’estensione di un diritto venga vista in modo tanto negativo. Un diritto che prima veniva goduto solo da alcuni, ora può essere esteso ad altri, senza nulla togliere a chi già prima ne godeva. Ricordano un po’ i bambini piccoli quando nasce un fratellino: hanno paura che i genitori tolgano loro tutto o parte dell’affetto che nutrono per loro. Solo che i commentatori di cui parlo sono adulti e dovrebbero capire che estendere un diritto significa “allargarlo”, non perderlo.
E l’Italia, le Istituzioni, il Governo come reagiscono? Sorprendentemente in modo tempestivo e con iniziali dichiarazioni favorevoli alla sentenza della Corte.
Ma siamo o non siamo in Italia? Siamo o non siamo un Paese che, in materia di parità di diritti tra donne e uomini, procede un passo avanti e due in dietro? Ed allora, ecco che si dice, in una bozza di ddl: “Sì, lasciamo la possibilità di dare il solo cognome della madre, ma subordiniamo questa possibilità all’accordo di entrambi i genitori“ E se per caso il padre non fosse d’accordo? La mia domanda è legittima. Le maggiori resistenze, in questo campo, sono maschili.
EDIT: Ottobre 2014 Alla fine di settembre, è stato approvato alla Camera il testo unico sul cognome che sancisce piena libertà nell’attribuire il cognome alla prole.
I bambini e le bambine, pertanto, potranno portare indifferentemente il cognome della madre o quello del padre, o anche tutti e due, in ordine alfabetico, opzione, questa, obbligatoria, in caso di mancato accordo tra i genitori.
In caso di riconoscimento tardivo di uno dei genitori, al figlio si apporrà il secondo cognome, solo se l’altro genitore è d’accordo e se c’è accordo anche del figlio che abbia almeno 14 anni.
In caso di figlio adottivo, si antepone al cognome originario solo uno dei cognomi dei genitori, a libera scelta. In mancanza di accordo, si prende il primo in ordine alfabetico.
Altre norme, rispettose della parità tra i coniugi, sono sancite in caso di figlio maggiorenne e di genitori con più di un cognome.
Le nuove regole saranno operative solo dopo l’approvazione di un regolamento apposito che deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
In attesa, i coniugi possono aggiungere al cognome paterno, quello materno.
(Come fonte per il post: L. Garlati “La famiglia tra passato e presente”, Giuffrè editore, 2011 e qui)


Qui comincerebbe la vera rivoluzione.