di Nicole
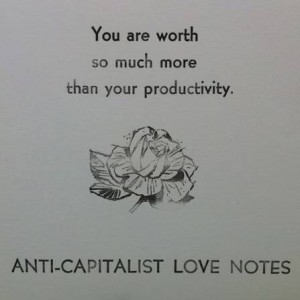 Nomade, precaria, queer.
Nomade, precaria, queer.
E’ incazzata ma pensa che le persone facciano del male solo per ignoranza.
Ha molti interessi e non ha ancora deciso cosa vuole fare da grande.
Lo scorso 8 novembre si è tenuta nello storico Rio Cinema di Dalston la terza edizione del London Sex Worker Film Festival, organizzata dalla Sex Worker Open University.
La SWOU è un collettivo creato “da e per i sex workers”, con una base a Londra e una a Glasgow.
I suoi obiettivi principali sono la creazione di un tessuto di solidarietà tra i sex workers e l’empowerment della comunità attraverso dibattiti, convegni, eventi culturali e progetti artistici. Dal punto di vista della policy, l’obiettivo della SWOU è la lotta contro la criminalizzazione. In Inghilterra, infatti, se il pagamento di un corrispettivo per una prestazione sessuale non è di per sé illegale, sono criminalizzate molte attività collaterali al lavoro sessuale, come l’adescamento in luoghi pubblici o varie forme di favoreggiamento della prostituzione; e in Irlanda del Nord dallo scorso gennaio è illegale anche l’atto di pagare un compenso per un servizio sessuale.
Il lavoro compiuto dalla Sex Workers University vuole però essere anzitutto un lavoro culturale, volto a mettere in discussione le narrazioni tradizionali e stereotipate intorno ai lavoratori del sesso: in particolare, la SWOU si propone di combattere la dicotomia mediatica “prostituta felice/vittima” e mostrare invece la vastità, la diversità e la complessità dei vissuti e delle esperienze che vengono comunemente appiattiti sotto l’unica etichetta di “prostituzione”.
In questa prospettiva, al Sex Worker Film Festival sono stati proposti un lungometraggio e sette corti, tutti realizzati da sex worker o ex sex worker, o sotto la loro supervisione, nella convinzione che soltanto l’autorappresentazione possa dare conto accuratamente e senza facili stereotipi della quotidianità , della vita e dei problemi di chi è coinvolto in una realtà.
, della vita e dei problemi di chi è coinvolto in una realtà.
Il solo lungometraggio in programma, Red Umbrella Diaries (2015), è un documentario che racconta le vite di sette sex worker newyorkesi: due uomini e cinque donne, impiegati in diversi settori del lavoro sessuale. I sette protagonisti si alternano sul palco del pub Joe’s per raccontare ciascuno il proprio percorso, il proprio rapporto con il lavoro, l’impatto del lavoro sul resto della vita e sulle relazioni con familiari e amici. Mentre telecamera li segue nel backstage e in alcuni luoghi del loro quotidiano, la storia raccontata è di volta in volta dura, commovente, buffa.
Presentato per la prima volta lo scorso settembre al Portland Film Festival, quella del Sex Worker Film Festival era la prima rappresentazione europea.
Allo stesso modo, l’accostamento di cortometraggi molto diversi tra loro ha mostrato, anzitutto, quanto è complesso quello di cui parliamo quando parliamo genericamente di sex work.
Il primo corto in programma, Documentary of a Peep Show Girl mostrava con uno sguardo divertito la protagonista bianca e occidentale al lavoro all’ interno della sua vetrina, impegnata a mostrarsi e parlare con i suoi clienti.
Becky’s Journey invece raccontava la storia di una donna di 26 anni che dalla Nigeria ha tentato due volte di raggiungere l’Europa per potersi prostituire, una delle quali in condizioni estreme: avendo fallito entrambi i tentativi, sta cercando il modo di provare una terza volta. Soy negra, soy marica, soy puta (Sono negra, sono queer, sono puttana) era un documentario sulla figura di Diana Navarro: sex worker e attivista colombiana, è stata la prima donna transgender nel suo Paese ad essere ammessa all’università, dove ha studiato legge per portare avanti meglio il proprio attivismo.

In All That Sheltering Emptiness, mentre passavano sullo schermo fotografie di lussuosi interni di alberghi newyorkesi, una voce maschile fuori campo parlava in prima persona di uno stupro che aveva subito da un cliente, e della sua difficoltà nell’articolare e dare un nome a questa esperienza. Roxanne raccontava l’amicizia tra una sex worker transgender e una bambina abbandonata a se stessa. Beautiful Monotony rappresentava la serata lavorativa tipo di una lap dancer: senza mostrare i volti, venivano riprodotti a velocità tripla sullo schermo l’alternarsi dei clienti, la ripetizione dello stesso ballo davanti a ciascuno di loro, le differenze e le somiglianze nelle reazioni, con un effetto molto simile a quello della celebre scena della catena di montaggio in Tempi moderni, e il doppio risultato di una grande comicità e di un’efficace rappresentazione del lavoro sessuale nel suo aspetto più meccanico e ripetitivo, da catena di montaggio, fornitura ripetuta di un servizio.
Puta Mestiza (Puttana Meticcia), il corto di chiusura, era il più duro e il più apertamente politico: con un discorso che ricalcava La Conciencia de la Mestiza di Gloria Anzaldúa per stile e impostazione, la protagonista, nuda in una vasca da bagno, discuteva della libertà di migrare per intraprendere il lavoro sessuale, del profondo legame tra l’attuale situazione del sex work e il colonialismo, del corpo come punto di partenza per l’azione politica, per poi incidersi la scritta puta mestiza sulla pelle come un marchio, con una lametta.
Quando sono uscita dal cinema, avevo in mente talmente tante frasi e immagini potenti che non saprei da dove cominciare se dovessi fare un’esposizione gerarchicamente ordinata delle complessità e delle vastità che questo festival mi ha mostrato.
Insistendo molto su precarietà e colonialismo, uno dei suoi obiettivi primari e più immediati era senza dubbio politico, e consisteva nella volontà di dimostrare che, tra le opzioni percorribili, soltanto la decriminalizzazione del lavoro sessuale può garantire un effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita di chi vi è impegnato.
Ma la potenza di questo festival risiedeva nel fatto che l’agenda politica risultava come la conseguenza quasi sottesa di un messaggio di maggiore portata.

Uno dei temi più ricorrenti, nei discorsi delle varie voci che hanno preso la parola, era quello del lavoro sessuale come esperienza trasformativa, conoscitiva e, soprattutto, di relazione con gli altri. Diana Navarro dice nel documentario che per lei il sex work è stato un modo “per vedere il mondo com’è davvero, per vivere fuori dalla bolla, dalla mia comfort zone”. Allo stesso modo, una delle protagoniste di Red Umbrella Diaries parlando del suo lavoro dice: “mi ha insegnato molto sulle persone, mi ha reso più comprensiva e compassionevole”.
L’attenzione all’impatto del sex work sulla vita privata di chi lo pratica e l’insistenza sul carattere relazionale di questo tipo di attività sono volte allo stesso obiettivo: quello di combattere la pericolosissima retorica che, assumendo che i lavoratori del sesso vendano il proprio corpo (e dunque se stessi), porta a disumanizzarli.
Diana Navarro lo spiega:
“I sex workers non vendono il proprio corpo, vendono servizi prodotti attraverso il corpo, come ogni altro lavoratore. L’unica differenza è che noi usiamo i genitali”.
Allo stesso modo, una delle protagoniste di Red Umbrella Diaries insiste su un aspetto che dovrebbe essere ovvio, ma che invece fatica ancora a imporsi nella nostra cultura in generale, e quando si parla di lavoro sessuale in particolare: “Il mio lavoro è una cosa che faccio, non una cosa che sono”.
L’obiettivo principale e più potente di questo festival, pienamente centrato, era quello di tracciare, nelle parole di una delle protagoniste dei documentari, un sentiero per umanizzare le lavoratrici e i lavoratori del sesso.
